 Il mio primo bambino compirebbe 22 anni questa settimana. Ero una diciassettenne tossicodipendente che non aveva finito il liceo, ma quando la signora col camice mi disse che ero incinta, già mi pensavo come una nuova madre.
Il mio primo bambino compirebbe 22 anni questa settimana. Ero una diciassettenne tossicodipendente che non aveva finito il liceo, ma quando la signora col camice mi disse che ero incinta, già mi pensavo come una nuova madre.Tutti volevano che abortissi… tranne me.
Infatti smisi di far uso di droga, andai in biblioteca, presi il libro “Under 18 and Pregnant” (minorenne e incinta) e cominciai a leggerlo per prepararmi. Prenotai il primo controllo per la gravidanza. Il mio ragazzo fu implacabile. Non scenderò nei dettagli della violenza che mi usò, reale e minacciata, ma alla fine cedetti all’insistenza del mio ragazzo di non tenere il nostro bambino. Il 4 gennaio 1989 mi portò alla clinica per aborti, ma io letteralmente ne scappai nella speranza di salvare il mio bambino. Due giorni dopo, il 6 gennaio 1989, a nove settimane e mezzo di gravidanza, abortii. Tentai il suicidio tre volte dopo l’aborto e dopo tutto questo finii ricoverata per un mese in un reparto psichiatrico di un’ospedale.
Fui forzata ad abortire e pensavo che diventando una ‘counselor’ di una clinica per aborti [‘counselor’ non ha un esatto equivalente in italiano, si potrebbe tradurre con consulente-psicologo; in questo caso è chi effettua i colloqui con le donne che si rivolgono alla clinica], avrei potuto aiutare le altre come me a tirar fuori i loro veri sentimenti sulla questione, esplorare le possibili alternative, e aiutarle a prendere una decisione onesta e informata, o aiutarle ad abbandonare una situazione in cui subivano abusi. Ho lavorato ad una clinica per aborti – non quella dove avevo abortito – per cinque anni, dai miei 18 a 23 anni. All’inizio gestivo le telefonate, poi lavorai al banco dove facevo l’accettazione dei pazienti e ricevevo i pagamenti, poi imparai un po’ di assistenza medica e lavorai al laboratorio, facendo le misurazioni dei segni vitali e facevo i “dischi” nell’area dell’autoclave (tornerò su questo più tardi).

Poi, dopo due anni di lavoro alla clinica e avendo cominciato il corso di diploma in psicologia, mi istruirono nel ruolo di ‘counselor’. L’esperienza di ‘counseling’ non era come speravo. Quasi tutte le donne incinte che venivano alla clinica per ‘counseling’ sulle opzioni avevano già preso la loro decisione, ma volevano controllare il posto, avere risposte alle proprie domande e forse attenuare le proprie paure. La maggior parte delle donne che entravano sentivano di non avere altra scelta. Poche erano davvero indecise. E qui il movimento pro-choice e le cliniche falliscono. Certo, avevamo un piccolo taccuino con i nomi e i numeri di due organizzazioni per le adozioni, ma nessuno ci aveva mai addestrato o insegnato su come funzionasse la faccenda così che potessimo spiegarla alle donne. Avevamo il numero dell’ufficio locale del programma WIC [che assiste le mamme e le donne incinte in condizioni economiche disagiate], dell’assistente sociale, ecc. ma non sapevo niente su come funzionasse la cosa se qualche donna mi avesse mai chiesto i particolari. Se una donna incinta avesse voluto sapere di più sulle altre scelte, il ‘counselor’ poteva fornirle al massimo un post-it con un numero telefonico scarabocchiato sopra in fretta.
Dopo aver preso il diploma in psicologia lasciai il mio lavoro alla clinica e lavorai per un anno al turno di notte di un servizio di assistenza telefonica per adolescenti, poi mi trasferii a New York per frequentare il master. Dopo aver preso il master in psicologia tornai alla mia città natale e lavorai part-time alla clinica per buona parte della gravidanza successiva. Ricordo un sabato mattina – un grande “giorno di procedure”: più di venti aborti erano stati prenotati e c’era una dozzina di manifestanti fuori, in piedi sulla via d’accesso che porta al parcheggio della clinica – ero incinta di circa sei mesi e molto visibilmente, ben oltre il limite della clinica di 16 settimane – quando un manifestante mi gridò: “Il tuo bambino ti ama!”. Sorrisi tra me e me. Quando entrai e cominciai ad aiutare l’infermiera a preparare la stanza post-operatoria glielo dissi e lei rimase arrabbiata e sbigottita. Anche allora che ero una dipendente attiva della clinica, dire a una donna incinta che il suo bambino la ama non mi sembrava una cosa sgradevole da dire, o anche da gridare, a una donna in evidente stato di gravidanza.
L’identificarmi come pro-life, però, avvenne solo molti anni dopo. Dopo essermi finalmente perdonata per aver abortito il mio primo bambino, riuscii a vedere il mondo in un modo diverso. Dopo due matrimoni falliti, riuscii finalmente a impegnarmi e ora sono sposata con mio marito da undici anni. Dopo avere fatto nascere tre figli maschi e aver sentito la vita crescere dentro di me e conoscendo l’ardente e travolgente amore che una madre può provare per un figlio, sono riuscita a capire finalmente che, sì, la vita comincia nel momento del concepimento. Ma fu solo dopo essere incappata nei link ai video di Abby Johnson [qui la sua testimonianza in italiano], e poi aver letto il suo libro ‘Unplanned’ [letteralmente ‘non pianificato’, ma il titolo richiama il nome della maggiore multinazionale degli aborti, Planned Parenthood, ‘Genitorialità pianificata’, di cui Abby Johnson era dirigente locale] che potei dire ad alta voce di essere pro-life. È stata la sorprendente storia di Abby, e la sua testimonianza coraggiosa e schietta, che mi ha aiutata ad unirmi apertamente alle file del movimento pro-life.
E anche se ora mi considero pro-life, non posso proprio sopportare gli estremisti che si trovano nelle file del movimento, e che spesso agiscono senza che tanti esponenti di spicco del movimento dicano una parola contro di essi. Ero al banco d’accettazione quando la clinica venne invasa il 22 luglio 1992, che poi abbiamo chiamato “il mercoledì dall’inferno”. Sei persone entrarono di corsa nella sala d’aspetto con un grosso aggeggio di metallo con diversi tubi attaccati, e che noi tutti credevamo essere una bomba, fino a quando non fecero scivolare le loro braccia al suo interno e cominciarono a cantare. Stettero nella sala d’aspetto “attaccati” a quella cosa per sette ore mentre la polizia locale, quella di stato e gli agenti dell’FBI cercavano di negoziare con loro e di estrarli da quell’aggeggio. Fecero la pipì sul tappeto. Le ordinarie funzioni della clinica continuarono in altre parti dell’edificio. Nessuna donna cambiò idea a seguito di quella invasione.
Stavo lavorando all’accettazione anche il giorno in cui due cliniche di Boston furono attaccate da un antiabortista armato che ferì cinque persone e ne uccise due. Passarono molte ore prima che l’uomo fosse arrestato. Boston è a cinque ore d’auto da dove lavoravo e rimasi al banco di accettazione. Mio zio, un sergente della polizia, insistette affinché portassi al lavoro un giubbotto antiproiettile per la settimana seguente quell’evento, e lo feci. A una delle precedenti direttrici della clinica per cui lavoravo fecero due volte irruzione in casa, un’altra direttrice aveva la propria casa sistematicamente soggetta a picchettaggio ed è stata seguita da casa al lavoro da veicoli sospetti in diverse occasioni. Deve esserci un modo migliore per promuovere la causa della vita [sono anch’io convinto che questo sia un pessimo modo di servire la vita, ndT].
E a proposito: l’aborto termina la vita. Punto. Questo non è in questione né dovrebbe esserlo. Questa è una verità fondamentale. Lavoravo nella sala dell’autoclave dove i “prodotti del concepimento” – così come tanti sostenitori pro-choice e assistenti della clinica per aborti chiamano il feto e la placenta – venivano ricomposti e contati per essere sicuri di “aver preso tutto”. Per gli aborti precoci, questo significava far galleggiare il contenuto del barattolo nell’acqua per visionare i villi corionici. Per aborti da circa 8 settimane e mezzo a 12 settimane, questo significava contare mani e piedi, assicurarsi che ci fossero la colonna vertebrale, il torace ed il cranio, tanto perché vi facciate un’idea. Per gli aborti dove l’età del feto era dubbia, specialmente se c’era la possibilità che fosse un “oops”, ovvero una gravidanza interrotta oltre il limite legale della clinica di 14 settimane dall’ultimo periodo mestruale [12 dal concepimento], i piedi venivano misurati per determinare più accuratamente l’età gestazionale.
Per quanto mi riguarda, in cuor mio so che non riuscirei mai più a porre fine ad una gravidanza, MAI PIÙ – né lavorare ancora in una clinica per aborti. Se qualcuna a me cara dovesse affrontare una gravidanza, farei del mio meglio per aiutarla a trovare il modo di restare incinta e dare a quel bambino una possibilità, o diventandone genitore, o dando il bambino in adozione.
Ci sono davvero troppe vite innocenti che vengono fatte fuori nel nostro paese prima che abbiano la possibilità di fare il primo respiro, e come nazione dovremmo fare di meglio.
 Dobbiamo fare meglio. Dobbiamo dare delle risorse concrete alle madri incinte che affrontano una gravidanza inattesa. Le donne e i bambini del nostro paese meritano meglio. Dopo tutto, le cose migliori della vita non sono pianificate.
Dobbiamo fare meglio. Dobbiamo dare delle risorse concrete alle madri incinte che affrontano una gravidanza inattesa. Le donne e i bambini del nostro paese meritano meglio. Dopo tutto, le cose migliori della vita non sono pianificate.Buon noncompleanno, nonbambino. Mi manchi ogni giorno.
Con amore e lacrime, Mamma.
Jewels Green
Exclusive: Former Abortion Clinic Worker Speaks Out For Life


















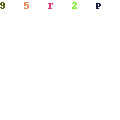
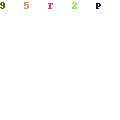

0 commenti:
Posta un commento