 Sono una donna di 47 anni, sposata con un mio coetaneo, e madre di due splendidi figli gemelli di 8 anni.
Sono una donna di 47 anni, sposata con un mio coetaneo, e madre di due splendidi figli gemelli di 8 anni.Io e mio marito ci siamo sposati a 26 anni con l’intenzione di non diventare genitori subito, ma di prenderci, prima, un po’ di tempo per noi.
Dopo i trent’anni abbiamo iniziato a pensarci seriamente.
Purtroppo, non accadeva mai niente: il ciclo mestruale si ripeteva regolarmente e la mia pancia rimaneva sempre piatta. Così, dopo un po’ il nostro desiderio di diventare genitori cominciò a crescere proporzionalmente alla nostra sfiducia. Ricordo una frase che ripeteva spesso mio marito a quel tempo: “Perché noi no?”
Ci siamo rivolti a diversi specialisti sottoponendoci entrambi a visite e controlli a volte penosi e dolorosi. Mio marito ha subito addirittura un intervento chirurgico. Siamo stati anche in un paio di centri di riproduzione assistita: ogni volta io non sono riuscita proseguire perché non potevo accettare quelli che i medici chiamano “protocolli” che prevedevano, allora, prima della legge 40, iper-stimolazione ovarica, super-produzione di ovuli da fecondare poi tutti con il seme del marito (nel mio caso), impianto di tre “pre-embrioni” (così li chiamavano loro) nell’utero materno e congelamento di tutti gli altri. Quando io chiedevo cosa sarebbe successo agli altri, mi sentivo congelare tutta anch’io e ce ne tornavamo a casa sempre più sconsolati. Non ricordo proprio chi una volta mi aveva regalato un libro che parlava di riproduzione assistita. In fondo c’erano le testimonianze di alcune donne che l’avevano praticata. Quella che più mi aveva colpita riguardava una madre di una bambina che però aveva altri figli dentro ad un congelatore di un laboratorio. Siccome stavano per scadere i termini oltre i quali il laboratorio non avrebbe più conservato i suoi bambini, lei doveva decidere cosa farne. Aveva quattro possibilità di scelta: provare un’altra fecondazione assistita, “donarli” ad un’altra coppia, “donarli” alla scienza per la ricerca, oppure farli “distruggere” (vale a dire lasciarli morire).
Io non avevo nessuna intenzione di mettermi in una simile situazione!
Allora ho cominciato a pensare all’adozione. Ad un certo punto, per brevi periodi, abbiamo ospitato a casa nostra un ragazzino ucraino. Siamo andati a trovarlo anche nell’orfanatrofio dove viveva. Io volevo quel bambino di 5 anni che nessuno aveva accolto. Impazzivo di dolore a pensarlo là, in quel posto lontano e triste. Ma bisogna sempre essere in due per volere un figlio e bisogna essere anche abbastanza forti e intelligenti da dire tutto quello che si sente dentro. Mio marito ogni tanto mi diceva: “Mi piacerebbe vedere come verrebbe fuori un figlio da me e te messi insieme”. Così ho capito che l’adozione non era la soluzione per la nostra coppia. Ancora adesso mi chiedo quanto male ho fatto a quel bambino...
Purtroppo, io soffrivo tantissimo della mia condizione di donna sposata senza figli: mi sentivo incompleta, non degna, non adatta. Le persone attorno non ci chiedevano neanche più niente... solo ci compativano. Magari qualche parente o qualche amico, ci “prestava” ogni tanto il figlio. Ma io non provavo nulla per questi figli di altri. Sono insegnante di scuola media, ma a quel tempo insegnavo in una scuola elementare e vivevo costantemente in mezzo ai piccoli: era un continuo ricordare la mia condizione.
Ho cominciato a stare male dentro: non volevo vedere nessuno, mi chiudevo in casa senza rispondere né al telefono né al campanello di casa. Mi sono preoccupata quando sono arrivati gli attacchi di panico. Allora mi sono rivolta ad uno specialista che mi ha consigliato dei farmaci e una psicologa: ho preso i farmaci e gli attacchi di panico sono cessati, ma la psicologa mi stava proprio antipatica e così l’ho mollata!
Psicologicamente mi sentivo meglio. Tanto che, quando un’amica, all’ennesimo tentativo di fecondazione artificiale fallito, mi sfidò dicendomi che avevo paura di provare, mi sentii ferita nell’orgoglio e decisi che avrei affrontato anche questa “cosa”, almeno un paio di volte, per non dovermi pentire quando poi sarebbe stato troppo tardi a causa dell’età che avanzava inesorabilmente.
Così ci siamo rivolti allo stesso centro di fecondazione assistita dei nostri amici. Questa volta, era uno dei più famosi in Italia: dopo anni di attesa e di peregrinare eravamo proprio decisi. D’altronde, col tempo, tutto aveva acquisito un significato diverso: ciò che prima trovavo assolutamente impraticabile non solo per le mie convinzioni morali, ma anche per quello che ritenevo scientificamente comprovato, ora era diventato relativo, relativo all’unica cosa che era davvero importante per me in quel momento: il mio desiderio di diventare madre! Non volevo più essere diversa dalle altre donne sposate. Per televisione e sui giornali si sentiva continuamente parlare di queste pratiche e di quante coppie ce l’avevano fatta. Alla fine tutto sembrava assolutamente normale.
Ricordo i momenti in sala d’attesa, gli esami clinici, le visite, i colloqui, le immagini rassicuranti alle pareti di bambini felici in braccio alle loro mamme. Ricordo anche le facce serie e tristi delle altre coppie: nessuno parlava, ma sapevamo di essere tutti in quel posto per lo stesso motivo.
Ero come anestetizzata, vivevo in stato di trance. Mi ero imposta di non pensare e di concentrarmi solo sul mio desiderio di diventare madre e di avere un frugoletto caldo e morbido tra le braccia. Accettavo tutto quello che mi dicevano e mi facevano senza discutere. Ricordo quando una dottoressa ci ha chiesto cosa avremmo voluto fare in caso di “pre-embrioni avanzati”. Per una frazione di secondo ho ripensato al libro letto anni prima, ma ho immediatamente rigettato quel ricordo nel “dimenticatoio”. Così abbiamo convenuto che la soluzione più logica sarebbe stata quella di congelarli.
Ricordo l’infinità di ormoni che mio marito mi iniettava quotidianamente e la mia amica, super efficiente, super sicura, che sapeva tutto, conosceva tutti e mi chiamava sempre per informarsi dell’andamento delle cose. Io, intanto, mi gonfiavo come un pallone e mi sentivo una mucca. Ricordo il giorno che sono andata dal parrucchiere e mi sono guardata allo specchio: faticavo a riconoscere quel viso pieno d’acqua. Ma non mi interessava, tanto sapevo che stavo facendo tutto per uno scopo, il più importante di tutta la mia vita!
Un 25 aprile mi hanno prelevato i 5 ovuli che avevo prodotto: non mi sentivo molto in gamba, la mia amica ogni volta ne produceva 8, 9... 10! Poi hanno fecondato i miei ovuli con lo sperma di mio marito. Infine, ce ne siamo tornati a casa lasciando in custodia al centro i nostri preziosi ovuli fecondati, che intanto si stavano velocemente trasformando.
Tutti i giorni telefonavo per sapere come stavano crescendo i nostri “embrioncini”. Purtroppo, uno non ce l’ha fatta perché era troppo debole ed è morto subito. Gli altri quattro, invece, crescevano bene.
Un primo maggio siamo ritornati al centro dove la solita dottoressa ci ha detto che dovendone impiantare tre, uno restava fuori. Quindi, ci ha chiesto cosa volevamo farne. Secondo lei, non valeva la pena congelarlo per un’eventuale seconda fecondazione dal momento che uno non sarebbe stato sufficiente. Quindi rimanevano solo due soluzioni: “distruggerlo” o “donarlo” alla ricerca. Noi abbiamo risposto... anzi, non abbiamo risposto perché per noi era lo stesso, in quel momento non ci interessava proprio. La dottoressa ci ha suggerito di lasciarlo alla ricerca, almeno così avrebbe avuto una sua utilità. E così abbiamo fatto. Ero quasi felice della scelta perché non dovevo rimanere con il pensiero di quell’embrione al freddo di un congelatore.
Poi, è arrivato il gran momento: un dottore in camice bianco, io, in camice bianco, stesa su un lettino bianco, un’assistente in camice bianco, dentro uno stanzino con pareti tutte bianche... un attimo ed era tutto fatto.
Sono uscita. Mio marito mi aspettava in una saletta adiacente. Siamo andati al parcheggio dove avevamo lasciato la macchia. Durante il ritorno, il mio compagno guidava lentamente, faceva attenzione a non sterzare bruscamente, era molto premuroso nei miei confronti.
Arrivati a casa, sono andata a riposare, ma dopo tre giorni ho preferito tornare a scuola, al lavoro.
I medici mi avevano detto di provare a fare il test di gravidanza dopo 14 giorni. Io, non potendo più resistere, dopo 12/13 giorni mi sono chiusa in bagno e l’ho fatto. Era una domenica. Le striscioline hanno cambiato colore: un rosa pallido, un po’ incerto, ma indubbiamente erano rosa. Non abbiamo voluto dire ancora niente a nessuno. La mattina dopo ho rifatto il test: il rosa era ancora più intenso. Ho telefonato immediatamente al centro, dove mi hanno consigliato di andare a fare il test in ospedale. L’ho fatto. Il giorno dopo l’ho ritirato. Ho aperto la busta scendendo per le scale: mi sembrava proprio di capire che i dati corrispondevano ad una gravidanza. Ho telefonato subito al centro: mi ha risposto lo stesso medico che mi aveva praticato il trasferimento. Appena gli ho letto il referto, ha esultato dalla gioia dicendo che era proprio orgoglioso di se stesso perché è rarissimo che il successo arrivi al primo colpo. Ricordo di essermi chiesta cosa mai centrasse lui.
A quel punto ho informato i miei genitori e gli amici. Tutti erano felicissimi per noi. Sono andata dal mio medico di base che mi ha fatto un’ ecografia. “Ci sono due cuoricini che battono, guarda” mi ha detto, tutto contento. Sono uscita di lì scombussolata, e cominciavo a chiedermi: “maschi o femmine?”, “Si assomiglieranno?”.
Infine, sono andata dal mio ginecologo. Mio marito mi ha accompagnata. Mi ha visitata e poi mi ha fatto l’ecografia: “Sono tre i cuori che battono” mi ha detto il medico. Mi sono sentita gelare tutta. Ho guardato il mio compagno che era ancora più sconcertato di me. Non avevamo mai sentito parlare di parti tri-gemellari. O meglio, avevamo sentito parlare di alcuni casi eccezionali per televisione. Ma noi non volevamo diventare dei fenomeni. Il medico disse che era presto. Non era assolutamente certo che sopravvivessero tutti e tre. Tornata a casa, ho telefonato al centro. Ho ritrovato il solito medico: piangendo, gli ho urlato tutta la mia disperazione. Adesso mi chiedo: “Ma di che cosa ero disperata? Non avevo tanto desiderato un figlio? Ora ne avevo tre!”. Eppure ero terrorizzata. Il medico mi fece ritelefonare dopo un quarto d’ora per mettermi in contatto con una psicologa. Le spiegai cos’era successo. Le dissi che io non volevo assolutamente tre figli. Mi rispose che la soluzione c’era. Mi diede il numero di telefono di uno studio medico di Milano. Telefonai, spiegai la mia situazione e fissai l’appuntamento. Andai dal mio ginecologo: lui, che si sentiva fiero di collaborare con due centri così importanti, con tono paterno, mi disse: “Signora, a volte le madri devono prendere delle decisioni difficili per il bene dei propri figli”. “Ma quale bene”, mi chiesi.
Mi fece tornare dopo qualche giorno per ritirare la documentazione dettagliata che lui mi aveva preparato.
Andammo a Milano. Lo studio aveva un arredamento essenziale, ma lussuoso. Tutto sembrava irreale, quasi sospeso: le pareti, i quadri, i mobili, le tende... Anche il medico ginecologo, e la sua assistente biologa sembravano provenire dall’aldilà. Ci chiamarono e di nuovo ripetemmo la nostra storia. Ci spiegarono cosa sarebbe successo. Ci dissero che avrebbero deciso loro quale dei tre non avrebbe più vissuto: avrebbero deciso in base a “valutazioni di tipo medico” e noi non avremmo potuto chiedere nulla, neppure il sesso. Mi praticarono l’amniocentesi. Senza anestesia. Mio Dio, quanto male! Ci fecero aspettare in sala d’attesa e dopo un po’ ci richiamarono. Ci dissero che aspettavamo due gemellini, uno maschio e l’altro femmina. Ci spiegarono che il terzo, a causa della sua posizione all’interno del mio utero, era quello destinato a non sopravvivere. Avremmo dovuto tornare dopo circa un paio di mesi per l’ “intervento” risolutivo del “problema”. Mi misi a piangere. Uscimmo, salimmo in macchina e si mise a piangere anche il mio compagno. Arrivammo a casa, aprimmo la porta di casa, mi buttai sul divano disperata e cominciai a tirandomi la pancia con le mani e a lanciare urli che sembravano provenire da un altro mondo. Mio marito mi portò a letto. Non ricordo quando e se mi sono più calmata. Confidai la storia a mia madre e a mio padre. Mia madre mi disse: “Fallo e non ci pensare più”. Decisi di andare a chiedere consiglio al mio medico curante, il quale mi disse: “Insomma, un aborto”. Io, confusa ormai all’inverosimile da tutta quell’ambiguità di linguaggio in cui ero immersa da troppo tempo, lo guardai perplessa e risposi: “No, un’embrio-riduzione”. Mi consigliò di riparlare con il mio ginecologo e di chiedergli che cosa si sarebbe potuto fare nel caso avessi deciso di tenere tutti e tre i bambini. Lo feci. Lui mi spiegò pazientemente che avremmo dovuto operare in stretto rapporto con la neonatologia di un ospedale vicino più all’avanguardia del nostro. Io ricordo bene in quale modo ponevo questa domanda: solo perché volevo in qualche modo alleggerirmi la coscienza. In realtà avevo già deciso che quel terzo bambino non avrebbe vissuto. Anche il medico, si capiva, preferiva questa soluzione. Lui mi metteva in guardia dai possibili rischi di malformazione. Mio marito pure temeva questa eventualità. Io no. Io dentro sentivo una flebile vocina che mi diceva: “Tu sei forte, sei di costituzione grande. Ci stanno tutti e tre dentro di te. Non succederà nulla.” Eppure ero decisa a volerne solo due. Perché? Perché non volevo sentirmi un fenomeno da baraccone. Perché ero così inscatolata nel pensiero comune che tre gemelli non potevano proprio rientrare nei miei rigidi schemi mentali. Volevo liberarmi di quell’assurdità che avevo nella mia pancia. Ad ogni controllo dal ginecologo speravo di non vedere più quel “coso” che pulsava sullo schermo della macchina per le ecografie. Invece c’era sempre. Ricordo i pugni contro lo sportello della macchina dopo l’ennesima ecografia. Ormai non c’era più possibilità di evitarlo: bisognava ritornare in quello spaventoso studio medico. E così tornammo. Piansi durante tutto il viaggio, in sala d’attesa, in ambulatorio. Ma quando il medico mi disse: “Guardi che non è mica obbligata a farlo”, risposi: “No, lo faccio”. La dottoressa mi disse: “Non vorrà mica distruggersi lei per i figli”, la guardai e pensai: “Ma questa cosa dice”. Fecero uscire mio marito e io mi stesi su quel lettino freddo e bianco e il medico mi infilò di nuovo l’ago iniettando non ricordo bene quale liquido. Il dolore fu lacerante. Continuavo a piangere.
 La dottoressa uscì e il medico girò, sadicamente, lo schermo della macchina per l’ecografia verso di me e vidi, vidi l’immagine di mio figlio morto: braccia e gambe alzate, completamente rigide. Soffocato da quel liquido, cosa avrà sentito? Quello che fino a quel momento avevo percepito come un’anomalia immaginandomelo quasi come un brutto tumore, ora appariva in tutta la sua pura e semplice realtà: un bambino, il mio bambino morto, ucciso da me, sua mamma. Girai sconvolta il volto, ma ormai era troppo tardi: l’immagine di mio figlio morto, ucciso da me, sarebbe rimasta per sempre nel profondo della mia anima. Continuavo a piangere. Appena uscita dall’ambulatorio, lo dissi a mio marito che mi aspettava in sala d’attesa. Non capivamo. Era ora di pranzo e la dottoressa, gentilmente, ci suggerì un bel localino dove andare a mangiare. Trovai assolutamente assurdo solo pensare di poter mangiare. Come potevo mangiare con un figlio morto in pancia? Come avrei potuto continuare a vivere in quelle condizioni? Poi, una sorta di sdoppiamento della personalità si impadronì di me. Credo fu un modo per salvarmi dalla pazzia. Al ritorno non parlavamo, né io né il mio compagno. Ci fermammo al lago di Garda, passeggiammo, guardammo le vetrine e i turisti e mangiammo un pessimo gelato. Da allora fino al momento del parto vissi come in un tempo sospeso. Una mia vicina di casa aspettava un figlio anche lei; era solo un mese più avanti di me. Anche questo fatto mi aiutò a non pensare troppo: andavamo a passeggiare insieme, confrontavamo le nostre pance, facevamo gli stessi controlli... Alla notte, però, era difficile sfuggire agli incubi.
La dottoressa uscì e il medico girò, sadicamente, lo schermo della macchina per l’ecografia verso di me e vidi, vidi l’immagine di mio figlio morto: braccia e gambe alzate, completamente rigide. Soffocato da quel liquido, cosa avrà sentito? Quello che fino a quel momento avevo percepito come un’anomalia immaginandomelo quasi come un brutto tumore, ora appariva in tutta la sua pura e semplice realtà: un bambino, il mio bambino morto, ucciso da me, sua mamma. Girai sconvolta il volto, ma ormai era troppo tardi: l’immagine di mio figlio morto, ucciso da me, sarebbe rimasta per sempre nel profondo della mia anima. Continuavo a piangere. Appena uscita dall’ambulatorio, lo dissi a mio marito che mi aspettava in sala d’attesa. Non capivamo. Era ora di pranzo e la dottoressa, gentilmente, ci suggerì un bel localino dove andare a mangiare. Trovai assolutamente assurdo solo pensare di poter mangiare. Come potevo mangiare con un figlio morto in pancia? Come avrei potuto continuare a vivere in quelle condizioni? Poi, una sorta di sdoppiamento della personalità si impadronì di me. Credo fu un modo per salvarmi dalla pazzia. Al ritorno non parlavamo, né io né il mio compagno. Ci fermammo al lago di Garda, passeggiammo, guardammo le vetrine e i turisti e mangiammo un pessimo gelato. Da allora fino al momento del parto vissi come in un tempo sospeso. Una mia vicina di casa aspettava un figlio anche lei; era solo un mese più avanti di me. Anche questo fatto mi aiutò a non pensare troppo: andavamo a passeggiare insieme, confrontavamo le nostre pance, facevamo gli stessi controlli... Alla notte, però, era difficile sfuggire agli incubi.Dopo il sesto mese di gravidanza andavo dal ginecologo tutte le settimane. Ad un tratto, all’ottavo mese, mi fecero partorire d’urgenza per gestosi. Un taglio cesareo e mi mostrarono i miei bambini. Per primo, mi portarono mio figlio così velocemente che non riuscii neanche a vederlo. Allora, pensai, “Adesso arriva anche lei. Devo stare attenta.” La vidi e non riuscii a trattenermi dal dire: “Che bella!”
Era mattina e verso sera ebbi un’emorragia a causa della quale stetti malissimo. Dovetti rimanere ricoverata per 10 giorni con i miei figli. La pressione arteriosa continuava ad rimanere alta, il latte non arrivava, i bambini non attaccavano al seno, e piangevano disperati dalla fame. Un sacco di gente veniva a trovarmi, medici e infermieri mi sgridavano, ma io non riuscivo a difendermi e mio marito non riusciva a proteggermi. Ricordo il giorno che ci dimisero: a mostrarmi quello che dovevo fare, una volta tornata a casa, era venuta apposta una pediatra che conoscevo bene perché avevo avuto suo figlio a scuola. Mio Dio, ero talmente agitata che non sapevo neppure da che parte prendere quei due batuffoletti. Erano così piccoli che non avevo una tutina che andasse loro bene.
Tornati a casa, mi prese il panico: come avrei fatto? Ero sì preoccupata dell’organizzazione della nuova situazione famigliare, ma soprattutto, avevo dentro qualcosa che mi tormentava. Mio marito stava passando un brutto momento a causa del lavoro ed era spesso via e quando era a casa faceva la sua parte con i bambini, ma non riuscivo a trovare conforto in lui per quello sentivo dentro. D’altra parte, chi confortava lui?
Arrivò il giorno del battesimo. Ricordo tutti i preparativi per una semplice, ma raffinata cerimonia, per un pranzo in un ristorante di lusso in una villa antica. Ricordo che solo un paio di giorni prima mi sono decisa ad andare a comprarmi un vestito per l’occasione. Ricordo le mie urla in macchina, finalmente sola, mentre andavo al negozio. Avevo anche un altro figlio che avrei voluto battezzare, ma ormai non potevo più. Non sarebbe mai più stato possibile. Mai più. Io battezzavo i miei figli vivi, ma continuavo a pensare solo a quello morto, anzi a quelli morti perché non potevo dimenticare neppure quello lasciato in quel centro tanto famoso. Ero assolutamente sdoppiata: con tutti mi dimostravo al colmo della felicità, mentre dentro, in realtà, ero una madre in lutto. Dopo il parto capivo finalmente concretamente chi avevo ucciso e continuavo a ripetermi: “Avrebbe potuto essere uno dei due vivi a morire!” Questo pensiero uccideva sempre di più anche me. Stavo morendo lentamente anch’io. Non ero più io quel corpo fisico. Mi trascinavo di giorno in giorno, ero irascibile, isterica, nevrotica. Non sapevo accogliere, consolare, calmare, coccolare, non capivo quei due bambini che tutti dicevano essere i miei figli e che piangevano sempre in un modo insopportabile, lacerante. Quel loro pianto mi faceva ricordare un altro pianto che non avevo potuto sentire, ma che potevo solo immaginare. E quel pianto diveniva sempre più inconsolabile perché io non riuscivo proprio a riconoscermi nel ruolo di madre con due figli vivi. Mi sentivo madre con due figli morti. E quell’immagine, quell’immagine di mio figlio ucciso da me era sempre lì, davanti ai miei occhi. Potevo solo fingere con gli altri di provare un’enorme gioia per i miei figli vivi, in realtà provavo solo un lacerante dolore per i miei figli morti.
In casa c’era la disperazione: i bambini erano sempre agitati, talvolta vomitavano e mio marito non sapeva più cosa fare.
Non andavamo neppure più a messa. Eppure prima andavamo, piuttosto regolarmente. Una volta avevo tentato di tornarci, ma la sensazione che avevo provato era stata tremenda: diversa, esclusa per sempre dalla comunità dei credenti. Dopo circa undici mesi ho potuto parlare con un sacerdote: era arrivato un nuovo parroco nella mia parrocchia. Piansi, piansi tanto. Lui mi disse: “Il Signore ti ha perdonato.” Io pensai che non bastava mi perdonasse il Signore. Tecnicamente per la Chiesa poteva anche esserci il perdono per una come me, ma ero io che non potevo perdonarmi. Come potevo perdonarmi una cosa simile? Io che ero sempre sta contro l’aborto, anche da giovane, da adulta l’avevo fatto. Come avevo potuto? E mio figlio, che avevo tenuto in grembo per quasi tre mesi, cosa poteva pensare di me, sua madre e degli altri due suoi fratelli sopravvissuti? Non si stava chiedendo “Perché loro sì e io no?”
Nei giorni seguenti parlai ancora con lui che finalmente mi ascoltava e mi sapeva dire qualcosa su cui poi potevo riflettere. In questo modo, mi rendo conto ora, potevo far divergere, almeno per un po’, la mia mente dal solito pensiero fisso. Così forse sono riuscita a non impazzire. Ho iniziato a leggere la Bibbia che prima non avevo mai preso in mano. Ho cominciato ad affidarmi sempre più a questo prete anche un po’ strano certe volte. Quando vedeva i miei bambini diceva: “Ecco i gemelli più belli del mondo!” ed è vero, sono sempre stati e sono molto belli. Però, mi facevano del male quando mi dicevano quanto erano belli perché pensavo che la loro bellezza inglobava anche quella degli altri due morti.
Abbiamo ricominciato, io e il mio compagno, ad andare a messa. E ricordo la prima volta che ho rifatto la comunione.
Un po’ alla volta ho cominciato a fare qualcosa in parrocchia. Più volte abbiamo anche litigato io e il nuovo parroco, ma poi sono sempre ritornata da lui. Poi ho anche capito che avevo bisogno di tornare da una psicologa e l’ho fatto. Questa mi ha seguita per due anni circa. Anche questo mi ha salvata. Quando lei però ha cominciato ad insistere che dovevo abbandonare l’ultima idea che mi era venuta in mente, il seppellimento dei bambini mai nati, la lasciai, senza tante spiegazioni, per continuare ad ascoltare la voce che sentivo dentro. Ormai avevo cominciato ad ascoltarmi dentro e a riflettere su tutto quello che mi accadeva. Ed era accaduto che un giorno, cercando in Internet tutta un’altra cosa, sono finita nel sito dell’associazione Difendere la Vita con Maria che si occupa proprio di promozione della vita nascente e del seppellimento dei bambini mai nati. Quella sera, rimasi davvero impressionata da questo fatto. Ricordo che spensi immediatamente il computer e quando tornò mio marito, lo pregai di guardare lui. Stampammo quello che ci sembrava più interessante e la mattina dopo telefonai. Trovai il presidente in persona. Gli spiegai come avevo trovato il sito e lui mi volle mandare dei libri contenenti le relazioni di vari interventi ai diversi convegni organizzati dalla sua associazione. Mi disse che vicino a noi c’era anche un altro sacerdote che si occupava della stessa tematica. Così andammo dal nostro sacerdote e attraverso lui conoscemmo l’associazione di cui ora facciamo parte.
Ora, tutto va molto meglio. Adoro e sono adorata dai miei figli che, grazie al Cielo, stanno crescendo bene. Fanno parte del gruppo dei chierichetti e tra poco faranno la loro Prima Confessione: ritengo una grande fortuna, ma forse non è un caso che a impartire loro questo Sacramento sarà lo stesso sacerdote che ha aiutato tanto me proprio attraverso lo stesso Sacramento.
Ora con il mio gruppetto prepariamo un incontro di preghiera al mese in favore della vita, organizziamo degli incontri formativi in parrocchia, collaboriamo con il Movimento per la Vita della nostra diocesi, abbiamo ottenuto di poter fare i seppellimenti anche nell’ospedale della nostra USL e siamo in attesa di poter fare il primo. Ho letto e leggo moltissimo: libri di religione e libri relativi alla “nuova cultura della vita” di cui parlava Giovanni Paolo II.
Ripensando a com’ero 9 anni fa, non mi riconosco proprio in quella donna fragile e insicura che si attaccava alle cose superficiali della vita per non sentirsi “diversa”.
Mi ritengo fortunata e ringrazio Dio ogni giorno per tutte le cose meravigliose che mi ha dato, anche per quelle che non ho saputo riconoscere, ma che ora, con il suo aiuto, sto cercando di trasformare in frutti buoni per me, per i miei figli e per quelli che ne hanno bisogno.
Ora insegno in una scuola media e mi piace moltissimo parlare con i miei ragazzi e stare con loro. Quando posso, faccio di tutto per aiutare qualcuno. Non riesco più a tacere quando qualcosa mi sembra ingiusto.
Chiedo a Dio solo due cose: la salute per i miei figli e la fede in Lui per continuare a fare quello che sto facendo con sempre rinnovato entusiasmo.
Forse, però, dovrei chiedere a Dio anche un po’ più di salute per me. Qualche mese fa, infatti, ho ricominciato ad avere problemi di pressione alta e delle strane reazioni simili ad attacchi panico. Sono andata dal mio medico curante, il quale mi ha prescritto un farmaco per la pressione e mi ha caldamente consigliato di dimagrire. Il farmaco l’ho preso e la pressione si è sistemata. Sono dimagrita di alcuni chili che però ultimamente ho recuperato. In questi anni sono aumentata di circa trenta chili. Le strane reazioni sono continuate e allora il mio medico mi ha prescritto pure un farmaco per gli attacchi di panico. In questi ultimi giorni ho avuto degli strani giramenti di testa che io ho imputato a stress: figli, famiglia,lavoro, volontariato... Sono ritornata dal mio medico che per una settimana mi ha tolto il farmaco per la pressione e me ne ha ordinato un altro per le vertigini...
Sarà la pre-menopausa, come dice il dottore? E, come dice sempre lui, dovrei semplicemente andarmene a passeggiare, senza prendermi tanti impegni, oltre alla mia famiglia e al mio lavoro?
Invece, io che sono una gran testarda, continuo ad ascoltarmi dentro e faccio tutto ciò che mi sento di fare, sperando nell’aiuto di Dio.
Signore, grazie per la vita che mi hai donato.
 Non vorrei vivere in un altro luogo, in un altro momento, circondata da altre persone se non quelle che mi hai messo accanto.
Non vorrei vivere in un altro luogo, in un altro momento, circondata da altre persone se non quelle che mi hai messo accanto.Non vorrei essere diversa da quella che sono.


















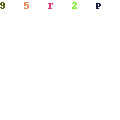
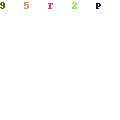

0 commenti:
Posta un commento